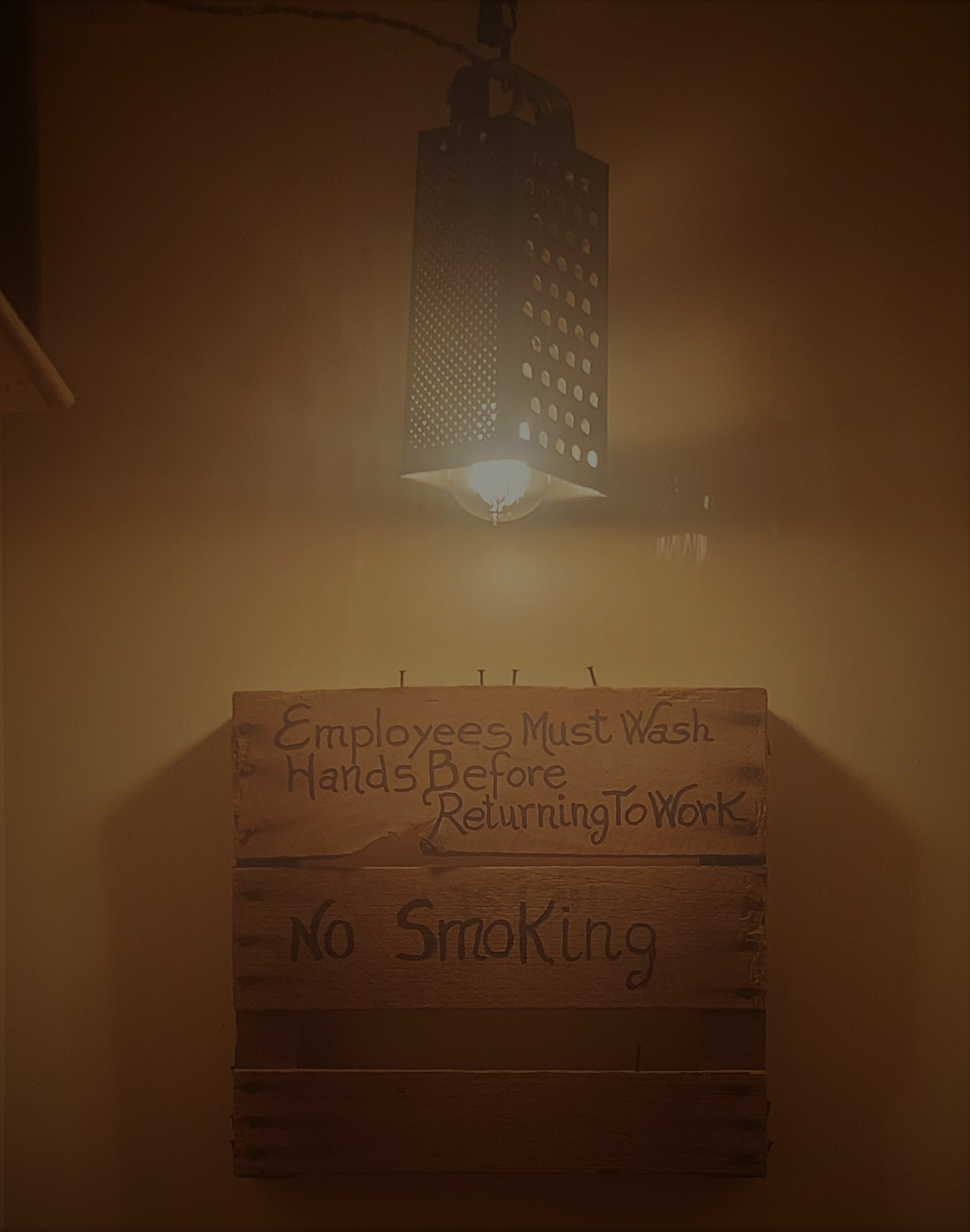APOLIDE
Sorge un sole magico fra le piccole alture che circondano il Lodge Damaraland. E’ un risveglio morbido, scevro da affanni. Siamo privi della solita lena organizzativa. Osserviamo gli zaini da ricostruire come fossero di chissà chi altro. Non sono ancora le otto e ci trasciniamo mollemente verso il buffet, che somiglia a un miraggio. La cucina propone piatti interessanti, tanto che la colazione si trasforma ben presto in pranzo. In effetti non avremo più fame prima di sera. Sento parlare italiano, e provo d’istinto un terrore vacuo, ma cerco di restare indifferente, imperturbabile, apolide.


Siamo rigenerati, ma Iri oggi ha una marcia in più. Quando si sveglia in queste condizioni diventa incontenibile, trasformandosi in una bomba di energia e ilarità per tutta la famiglia.
Vicky è sempre accanto a noi, e quando scoccano le nove ed è ormai ora di salutarsi, il dispiacere è reciproco. I suoi occhi buoni e luminosi sembrano quelli della Namibia. Li porteremo con noi. Non in senso letterale, naturalmente.
PETRIFIED FOREST
Oggi le nostre tappe sono disseminate lungo la C39, una strada sterrata, ma godibile. Dopo un’ora di marcia arriviamo nei pressi della Petrified Forest. I tronchi fossili che vi sono conservati risalgono a milioni di anni or sono, deposti da canali fluviali che da questo lato del tempo possiamo soltanto immaginare. Non sono molti, ma due di essi misurano fino a quarantacinque metri e hanno mantenuto la foggia originaria, nonostante siano in parte frammentati.


ARIZONA DREAM
Quindici anni fa io e Franci visitammo la Petrified Forest in Arizona. Il sito americano è molto più esteso di quello africano, ma non mi pare ci fossero tronchi fossili di queste dimensioni. Rammento quel luogo più che altro perchè fu la tappa intermedia fra due meraviglie americane: il Canyon de Chelly, sito nel cuore della Riserva Indiana Navajo, uno dei luoghi che più c’è rimasto nel cuore; il Meteor Crater di Wislow, un’enorme depressione nel deserto, il cui cratere fu generato dall’impatto di un asteroide del diametro di cinquanta metri.



Canyon de Chelly


U.S. Petrified Forest



Meteor Crater
ATTRAVERSO LO SPAZIO E IL TEMPO
La Foresta pietrificata di Khorixas rende l’idea della genesi del fenomeno che qui si verificò 280 milioni di anni fa. Lo scioglimento dei ghiacciai che coprivano l’Africa centrale provocò inondazioni immani, che travolsero e trasportarono ogni cosa per centinaia di chilometri, incluse queste grandi conifere ormai estinte.


Quelle acque, ricche di minerali come la silice, sostituirono gradualmente la materia organica delle piante, pietrificandole. Ed oggi possiamo ammirare tronchi di cristalli di quarzo perfettamente conservati, come in un fermo immagine che attraversi lo spazio e il tempo, e trascenda il senso stesso delle cose. E’ in effetti impressionante riflettere sulla trasformazione della materia, sul quarzo che sostituisce la lignina e la cellulosa concedendo che le forme restino tutto sommato inalterate; sull’indefinita vastità delle ere che si sono succedute prima di noi, su quante ancora verranno dopo l’età dell’uomo; su questo tempo possente che pare inafferrabile; su quanto tutto sia infinitamente grande e infinitamente piccolo e perciò impossibile da concepire.
Il tempo è proprio qui davanti ai nostri occhi, allucinante, pietrificato.
WELWITSCHIA MIRABILIS

Qui abbiamo anche l’opportunità di osservare da vicino la Welwitschia Mirabilis, una pianta straordinaria, un organismo talmente antico da essere considerato un fossile vivente. Essa è uno dei simboli della Namibia: è infatti raffigurata nello stemma nazionale, per via della sua longevità e della sua tenace resistenza all’ambiente arido e alle condizioni avverse di un deserto che la bracca e cinge d’assedio da ogni dove. Alcuni esemplari di Welwitschia vivono su questa terra da migliaia di anni, e sono annoverabili fra gli esseri viventi più vecchi al mondo. Le foglie che la caratterizzano si snodano contorte ai lati del tronco tozzo che ne costituisce il cuore. La pianta si nutre grazie a una radice profonda e alla nebbia carica dell’umidità dell’oceano. Un capolavoro di ingegneria naturale.
PARALLELE
La prossima tappa è la vallata di Twyfelfontein. Dopo un breve tratto di C39 svoltiamo a sinistra per la D2612, che si rivela ben presto insidiosa. E’ una strada di terra e pietra, modulata su più livelli paralleli molto stretti, e con lastricati taglienti che impongono ben più di una preoccupazione. Più ci avviciniamo alla meta e più la strada diventa impraticabile. Mi sposto a destra, a sinistra, poi sopra e sotto per trovare la via migliore. Ma non c’è scampo. A un certo punto una jeep del parco mi sorpassa a velocità sconsiderata. Arriviamo a destinazione tirando un sospiro di sollievo.
URI-AIS o TWYFELFONTEIN?





E’ mezzogiorno. Parcheggiamo sotto un telo di stoffa leggera ma efficace e in pochi minuti siamo a spasso con la guida di turno. Andiamo alla scoperta dei dipinti rupestri e dei graffiti dell’età della pietra che hanno reso famoso questo posto. Il nome originario della valle è Uri-Ais (“sorgente che zampilla”). I primi coloni bianchi, non trovando traccia della sorgente citata dai Damara, ribattezzarono il luogo Twyfelfontein (“sorgente incerta”). Spesso le cose hanno nomi tanto semplici quanto significativi. E possono mutare al variare di determinate condizioni. Come nel caso di una fonte d’acqua prosciugata.
LAVAGNA PRIMORDIALE?





Il sole adesso inizia a picchiare forte ma il clima resta secco e gradevole. Le incisioni rupestri di Twyfelfontein sono state realizzate dagli antenati dei San, un popolo di cacciatori-raccoglitori che viveva nella zona. Queste incisioni, che raffigurano animali, figure umane e simboli risalenti a oltre 1000 anni fa, sono considerate fra le più importanti collezioni di arte rupestre in Africa. In certi casi gli animali vengono raffigurati vicino alle proprie impronte, come se si trattasse di una sorta di mappatura delle specie utile a collegare un dato animale alle tracce lasciate sul terreno. Chissà che non servisse a educare i più giovani? E’ una passeggiata molto gradevole, in cui Irene, che si era svegliata con un piglio positivo e travolgente, inizia a dare piccoli segnali di cedimento e follia. Ciò verrà confermato dalle performance attoriali nelle ore successive.

90 KM ORARI CONTRO L’ATTRITO
Tornati al rover, faccio due chiacchiere con un ragazzo del luogo. Vorrei visitare Organ pipes ma mi spiega che la strada peggiora ulteriormente poi. E così rinuncio. Mi chiarisce anche che per ovviare alle lastre che tagliano trasversalmente la carreggiata dovrei procedere a una velocità minima di 90kmh. Mi sembra una follia ma decido di provare a seguire il suo consiglio. La velocità è sostenuta per una strada simile, ma attutisce notevolmente l’attrito col terreno. Occorre fare attenzione in curva, dove il rover derapa allegramente, ma in effetti così è un’altra vita. Resta la paura di bucare, sempre.
Riusciamo a scamparla, e arriviamo sani e salvi al Twyfelfontein Elephant Drives & Campsite. Ho prenotato un’escursione nel deserto la sera prima. Una signora è lì ad attenderci. Nella zona vivono alcune famiglie di elefanti del deserto. Ho letto da qualche parte che avvistarli sia un’esperienza magnifica, e non ci lasciamo sfuggire l’occasione.



Mentre attendiamo l’inizio del tour, incrociamo la famiglia di italiani che avevamo percepito al lodge Damaraland. Hanno appena terminato l’escursione. Ci raccontano che in mattinata hanno bucato in due occasioni; che la prima volta hanno sostituito lo pneumatico e che la seconda hanno dovuto chiamare un gommista locale. Chissà poi dove l’avranno trovato? Stento a credere alle loro parole, e poi rifletto sui rischi che abbiamo corso in quelle strade assurde percorse pochi istanti prima, strade da cui i nostri connazionali (non sono più apolide) si erano peraltro tenuti alla larga. Bucare in Namibia spesso non rappresenta un’opzione.
GLI ELEFANTI DEL DESERTO
Arriva la nostra jeep. Ci piazziamo dietro, ma quattro turisti nord europei niente affatto simpatici chiedono con forza un cambio di posto. Per non mettere in difficoltà il giovane e sorridente autista, veniamo incontro alle loro richieste. D’altronde noi siamo viaggiatori, non banali turisti.
Accanto all’autista c’è un ragazzino di 10 anni al massimo. E’ un bimbo sveglio, che credo dia una mano al driver ad individuare gli animali di cui siamo in cerca. Girovaghiamo in mezzo al deserto entrando e uscendo da piccole alture circondate da arbusti, in cerca del giusto punto di avvistamento. Dopo pochi minuti notiamo i primi esemplari. E’ un gruppo di 4-5 elefanti. Sono a pochi metri da noi, e l’emozione di vedere da vicino e in libertà questi animali meravigliosi è unica.




Per Gim e Iri è la prima volta. Osservo i loro volti prima di perdermi nella contemplazione degli elefanti. Sono fiero dei sacrifici fatti per mostrare ai nostri figli il lato più autentico della natura. Spero conservino a lungo in memoria le immagini di queste creature libere e selvagge.
Gli elefanti sono un po’ infastiditi dalla nostra presenza, per quanto l’autista utilizzi tutte le cautele del caso. Sembrano di dimensioni minori rispetto a quelli avvistati in Sudafrica. Rispettiamo un silenzio sacro per non spaventare o innervosire i pachidermi. Gli giriamo un po’ intorno, senza mai impedir loro il passaggio.
AMALGAMA


Il loro amalgama con l’ambiente appare profondo, anche sotto il profilo cromatico. Li osserviamo ancora un po’ prima di lasciarli andare. Il nostro è un modesto drappello privo di vessilli, al cospetto del passaggio dei Re. Li vediamo allontanarsi come navi maestose sopra un desertoceano, oltre il cui orizzonte svaniscono, fondendosi con la sabbia e il sole.
V8 INTERCEPTOR
A questo punto Mad Max aumenta i giri del V8 Interceptor, segno che ci stiamo spostando in un’altra zona. La caccia entra nel vivo. L’uomo ci spiega che una comunità più grande di elefanti si è spostata altrove. Ne chiede conferma agli abitanti di minuti villaggi che troviamo lungo il percorso. Alcuni ragazzini gli fanno distintamente cenno con la mano di proseguire per la rotta che stiamo seguendo. Siamo circondati da fiumi di sabbia e piccole oasi verdeggianti. Poi il deserto si fa via via più selvaggio e desolato.
UNA GIRAFFA IN SOGNO

D’un tratto avvistiamo una giraffa, elegantissima e imperturbabile. Non sembra vera, come tutto il resto. Ci osserva curiosa, senza perdere compostezza. E’ un animale spettacolare. Sembra scivolare via davanti ai nostri occhi, tanto i suoi passi sono aggraziati e leggeri. Si è alzato il vento e la sabbia si solleva in leggeri mulinelli che danzano in controluce attorno al corpo della giraffa. Le colline perdono consistenza in lontananza. Sembra una magia, un frammento unico in cui il tempo si spezza e tutto tace alla vista di siffatta bellezza.
Nel frattempo il vento ha preso a tirare sempre più forte. E’ un fattore che non abbiamo calcolato. Iniziamo a patire il freddo. La jeep è aperta su tutti i lati e ci prendiamo quello che viene, nonostante il nostro alloggiamento sia più riparato rispetto a quelli degli altri passeggeri.
REGATANDO SULLA SABBIA


A un certo punto la strada inizia a salire e a ridursi in ampiezza. C’è roccia ovunque. La salita s’impenna, finchè scavalliamo e ci troviamo di fronte un panorama che lascia senza fiato. Dinanzi a noi dilaga una valle spettacolare. Sembra di essere in avanscoperta su un pianeta alieno, a bordo di un mezzo rudimentale e futuristico allo stesso tempo. Incrociamo un elefante solitario, che si lascia avvicinare senza problemi.

Mad Max a questo punto pare indeciso, prende una direzione, poi un’altra. Imbocca una pista immaginaria e poi sterza repentinamente. Si consulta a più riprese col socio di scorribande. Non sembra avere le idee chiare sul da farsi, e noi iniziamo a soffrire sempre più il freddo. Ci stringiamo, coprendoci coi foulard e con gli zaini, ma non basta. L’esplorazione del pianeta prosegue implacabile. Non ci sono tracce, e il vento ulula. Andiamo a vela adesso. Regatiamo fra le onde di sabbia dell’ignoto. I marosi ci sollevano in cielo per poi farci planare sul pelo del deserto.
Sono quasi le 16, e inizio a pensare alla strada di ritorno. Stanotte dormiremo nel Kunene, siamo distanti e dobbiamo rifare tutto questo percorso a ritroso, oltre al viaggio fino alla nostra nuova casa. Il sole cala rapidamente in Namibia, e viaggiare di notte non è mai una buona idea da queste parti.
LA SCORTA
Finalmente avvistiamo una parte della famiglia di elefanti che abbiamo cercato a lungo. Sembrano nervosi, e capiamo ben presto perché. Hanno un cucciolo con sè, e lo scortano in modo organizzato, proteggendo con cura il lato “debole” della missione.




LA VARIANTE UMANA
Avverto distintamente la sensazione di rappresentare una minaccia per questi pachidermi, e ripenso ancora una volta al modo in cui ci siamo illusi di uscire dal mondo naturale, di pensare ingenuamente di poter essere altro da esso, di ergerci ad archetipo fra le forme di vita, quando rappresentiamo soltanto una delle innumerevoli varianti dell’esistenza sul pianeta.



Siamo minute ed estemporanee scintille in un incendio che divampa dalla notte dei tempi.
PICCOLI COLPI DI TOSSE
Osserviamo ancora un po’ la famigliola compatta e poi filiamo via. Sarei rimasto a lungo ad osservarli, ma la strada da fare è tanta. Il nostro mezzo inizia a dare qualche segnale di malfunzionamento fra le dune. Piccoli colpi di tosse. Il giovane namibiano scende, da un occhio al motore, controlla il telefono, ma non c’è campo e ripartiamo. Mad Max si dimostra abile e rapido su un terreno totalmente dissestato. Procediamo a grandi passi, subendo anche meno il vento in questa direzione. Risaliamo la vasta conca e torniamo nella parte più guidabile.
PIT STOP
Sono quasi le 17 quando il V8 Interceptor inizia a perdere potenza. Sembra ingolfato. Borbotta, e poi si spegne in mezzo all’ennesimo sconfinato nulla. I nostri eroi riaprono il cofano, armeggiano un attimo e poi chiamano qualcuno. Sembra ci sia un problema con la batteria. Non ci voleva. Per fortuna, dopo un quarto d’ora arriva una macchina. Un tizio scende, attacca i cavi, e torniamo in sella. Il mezzo ora sembra procedere bene. Vedo a pochi km il ranch da cui siamo partiti, osservo il sole calare inesorabilmente. Il fuoristrada borbotta ancora, tira colpi di tosse a ripetizione, sembra sul punto di morire, ma tiene duro e ci conduce esanime a destinazione.
Sono le 17e30. Fuori tempo massimo. Siamo grati ai ragazzi che ci hanno accompagnato. E siamo anche gli unici a ringraziarli per l’impegno profuso con un piccolo extra. Non mi stupisco, visto l’altezzoso distacco degli automi che erano con noi.
CORSA CONTRO LA NOTTE

Sgommiamo via veloci verso nord. La nostra destinazione è nei dintorni di Palmwag, nella regione del Kunene. Per fortuna la C39 e la C43 sono ottime strade. Posso percorrerle a buon ritmo, pigiando sull’acceleratore ma senza mai superare certi limiti. Guidare di notte in Namibia è pericoloso per via della fauna e della visibilità pressochè azzerata. Quindi devo anticiparne le mosse.
Il navigatore impazzisce ma verso le 19 avvistiamo una sorta di sbarramento, in cui due uomini in tenuta militare fanno sostanzialmente da filtro. Gli chiediamo informazioni e il tizio ci spiega che siamo arrivati. Il Palmwag Camp sembra spartano al punto giusto. Qui ho prenotato una notte in tenda per vivere un’esperienza diversa. Ma un upgrade automatico e gratuito implica che dormiremo fra quattro muri anche stanotte. E’ tardi, abbiamo fame e accettiamo l’upgrade.
CAOS CROMATICO CREPUSCOLARE IN ZONA TORRIDA


Ci diamo una ripulita e andiamo verso il ristorante. Ceniamo in una bella terrazza in legno, affacciata sul tramonto del Kunene. Abbiamo davanti un’Africa diversa adesso, più verde e misteriosa. Ci immergiamo nel caos cromatico crepuscolare della zona torrida. In dieci giorni non avevamo mai visto una vegetazione tanto densa. Le palme aggiungono un tocco esotico al contesto: sembra di essere Altrove per l’ennesima volta, rispetto a ieri, rispetto a una settimana fa, rispetto a ogni momento vissuto.


L’unica pecca della terrazza è di essere all’aperto. Non c’è vento, ma il freddo è pungente e si fa un po’ fatica a godersi la cena, anche se il vino supporta quanto meno noi adulti.
“HOW MANY OF YOU KNOW THAT YOU’RE REALLY ALIVE? BULLSHITS!!”


Facciamo due passi e poi ci ritiriamo. Prima di rientrare osservo la chioma di una palma lattea che si staglia nella notte nera, con miriadi di stelle a far festa tutto intorno, lungo le distese interplanetarie.
Quella chioma somiglia a Val Kilmer nei panni di Morrison, quando sale sul tetto di una macchina davanti al Whisky a go-go e grida: “Quanti di voi pensano di essere vivi? Quanti di voi sanno di essere veramente vivi?”
Alzo la mano nell’oscurità, osservo la palma Jim ridere di me, e chiudo a chiave la porta del nostro rifugio, sigillando un’altra giornata di grande valore.